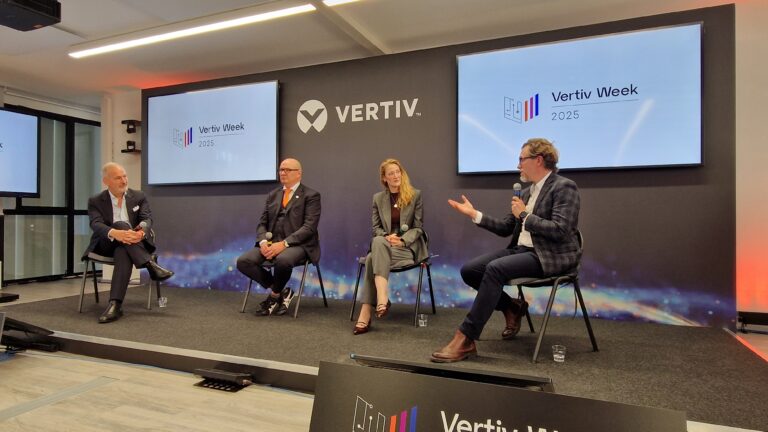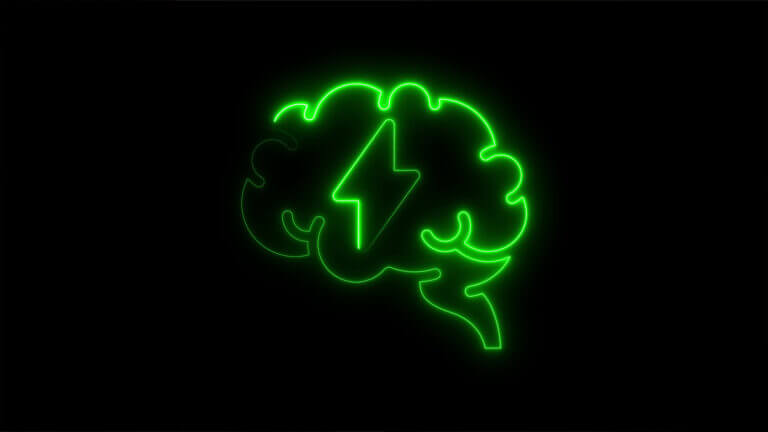L’evoluzione dei servizi digitali pubblici e l’impatto dell’intelligenza artificiale stanno rendendo sempre più evidente la necessità di rafforzare le competenze digitali di base nella popolazione. È uno dei passaggi centrali affrontati da Paola Liberace, Dirigente dell’Area Risorse Umane e Academy di AgID, nel corso della presentazione dell’Osservatorio sulle Competenze Digitali 2025 organizzato da Anitec-Assinform insieme ad AICA e Assintel. Le sue riflessioni offrono un quadro articolato delle criticità e dei progressi in atto, mettendo in relazione i dati europei del Digital Decade, il ruolo delle politiche pubbliche e le trasformazioni del mercato del lavoro.
Indice degli argomenti
La distanza dagli obiettivi europei e il ruolo delle iniziative PNRR
Il tema delle competenze digitali di base emerge anzitutto dai numeri. Secondo i dati del Digital Decade citati da Liberace, nel 2023 solo il 45% della popolazione italiana possedeva competenze digitali essenziali. Il confronto con il traguardo fissato dall’Unione Europea – raggiungere l’80% entro il 2030 – evidenzia «una lunga strada da fare» per colmare un gap strutturale. La dirigente chiarisce che i dati europei rappresentano una “proxy” meno accurata rispetto alle rilevazioni presentate dall’Osservatorio, ma la tendenza indicata è coerente: l’Italia resta indietro nella formazione digitale dei cittadini.
Liberace collega il tema agli interventi varati negli ultimi anni, in particolare alle misure PNRR. Tra queste, i punti di facilitazione digitale, promossi dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, hanno già coinvolto «2 milioni di cittadini», con programmi formativi distribuiti su tutto il territorio nazionale. La speranza, spiega, è che queste iniziative non producano soltanto alfabetizzazione tecnica, ma soprattutto curiosità verso i servizi digitali pubblici, in modo da trasformare la formazione in pratica quotidiana.
Competenze come esigenza reale: quando il digitale diventa una necessità
Uno dei passaggi più significativi dell’intervento riguarda la natura stessa delle competenze digitali di base. Liberace sottolinea che tali competenze diventano effettive solo quando nascono da un bisogno concreto: «la competenza digitale di base diventa vera quando diventa un’esigenza». L’esempio più evidente risale alla pandemia, quando l’uso dei servizi digitali è diventato obbligato e ha generato una domanda altrimenti latente.
Il tema riguarda anche la struttura demografica italiana. Il moderatore Giampiero Marrazzo richiama l’attenzione sull’invecchiamento della popolazione, chiedendo se il dato anagrafico incida sulla difficoltà di diffusione delle competenze. Liberace riconosce che «l’Europa è un continente vecchio che invecchia», con una forza lavoro che tende ad allungare la propria età attiva. Tuttavia avverte dal rischio di semplificare la questione contrapponendo nativi digitali e generazioni precedenti. L’obiettivo non è creare una linea di demarcazione, ma sostenere un percorso formativo continuo che renda operative tutte le fasce della popolazione, inclusi i cosiddetti «migranti digitali», cioè coloro che hanno visto nascere il digitale e ne hanno gradualmente adottato strumenti e linguaggi.
La crescente richiesta di professionisti ICT e la trasformazione delle imprese
La riflessione si sposta poi sul fabbisogno di competenze specialistiche. I dati presentati dall’Osservatorio, ripresi dal moderatore, indicano che i professionisti ICT rappresentano il 4% della forza lavoro in Italia, contro una media del 5% in Europa. Pur trattandosi di valori apparentemente contenuti, Liberace evidenzia che queste percentuali hanno un peso rilevante nel sistema produttivo. Le imprese di settori non ICT richiedono sempre più competenze digitali per integrare nuovi processi e tecnologie, segno di una digitalizzazione che sta entrando «nei processi produttivi e industriali» e non è più confinata alle funzioni tradizionalmente legate all’IT.
All’interno di questo quadro, la dirigente osserva che la domanda di competenze collegate specificamente a ChatGPT è in calo, ma interpreta il dato come un segnale positivo: non si tratta di un arretramento, bensì del consolidarsi di un approccio più maturo, in cui contano le capacità di utilizzare sistemi basati su AI in modo trasversale, comprese attività come il prompt engineering.
Il contributo di AgID ai servizi pubblici digitali e all’inclusione
L’intervento affronta poi le azioni che AgID sta sviluppando per rafforzare l’adozione dei servizi pubblici digitali e migliorare l’accessibilità. Liberace dedica particolare attenzione al progetto dell’IT Wallet, definito come «il nostro porta documenti digitali», utile sia per interagire con la Pubblica Amministrazione sia per gestire pagamenti e rimborsi. L’elemento centrale non è però la tecnologia in sé, quanto il suo posizionamento all’interno di un ecosistema più ampio. La visione dell’Agenzia non prevede un modello esclusivo, ma un wallet pubblico che dialoghi con soluzioni private già disponibili sul mercato, rendendo possibile un’esperienza «seamless» per i cittadini.
Un secondo ambito cruciale riguarda l’accessibilità digitale, affrontata attraverso la misura PNRR 1.4.2 “Citizen inclusion”. L’obiettivo, sottolinea la dirigente, è garantire servizi digitali realmente accessibili a tutta la popolazione, considerando non solo le disabilità permanenti ma anche quelle temporanee. Rendere la rete e i servizi digitali inclusivi significa rispondere alle esigenze dell’intera cittadinanza, non di una categoria ristretta. È una responsabilità che non riguarda solo le amministrazioni pubbliche, ma anche le imprese, chiamate a rispettare standard di accessibilità nei propri servizi digitali.
Le nuove competenze richieste dall’intelligenza artificiale
Il rapporto tra competenze digitali di base e intelligenza artificiale è tra i temi più attuali. Liberace ricorda che il quadro europeo DigComp, nato circa dieci anni fa, è stato aggiornato più volte e che la versione del 2022 aveva integrato solo parzialmente l’AI, senza includere gli aspetti legati alla generazione automatica dei contenuti. La nuova versione del DigComp, in fase di pubblicazione, introdurrà invece un’integrazione più strutturale dell’intelligenza artificiale generativa, con l’obiettivo di definire quali conoscenze e quali livelli di consapevolezza siano necessari per interagire con questi sistemi.
La dirigente insiste sul valore della consapevolezza cognitiva dell’AI. Non è necessario che tutti diventino esperti o professionisti del prompt engineering, ma è indispensabile sapere «che cosa è questo ente che abbiamo di fronte, fin dove ci possiamo spingere nell’interazione con esso, qual è il ruolo dell’uomo e qual è il ruolo della macchina».