L’evoluzione del data center costringe l’Europa a ripensare le proprie fondamenta tecnologiche. La crescita della domanda di servizi digitali, l’impatto delle nuove architetture computazionali, il fabbisogno energetico generato dai carichi ad alta intensità e la necessità di infrastrutture non solo più estese ma anche più capillari e sinergiche stanno definendo la mappa delle priorità industriali.
L’evento
Data center, l’Europa alla prova di AI, energia e sovranità digitale
Dal Green Deal alla NIS2, passando per l’AI and Cloud Development Act, l’Europa deve creare un ecosistema normativo e infrastrutturale coerente per sostenere la domanda di calcolo. Ecco le priorità strategiche emerse al Data Center Outlook 2026-2030
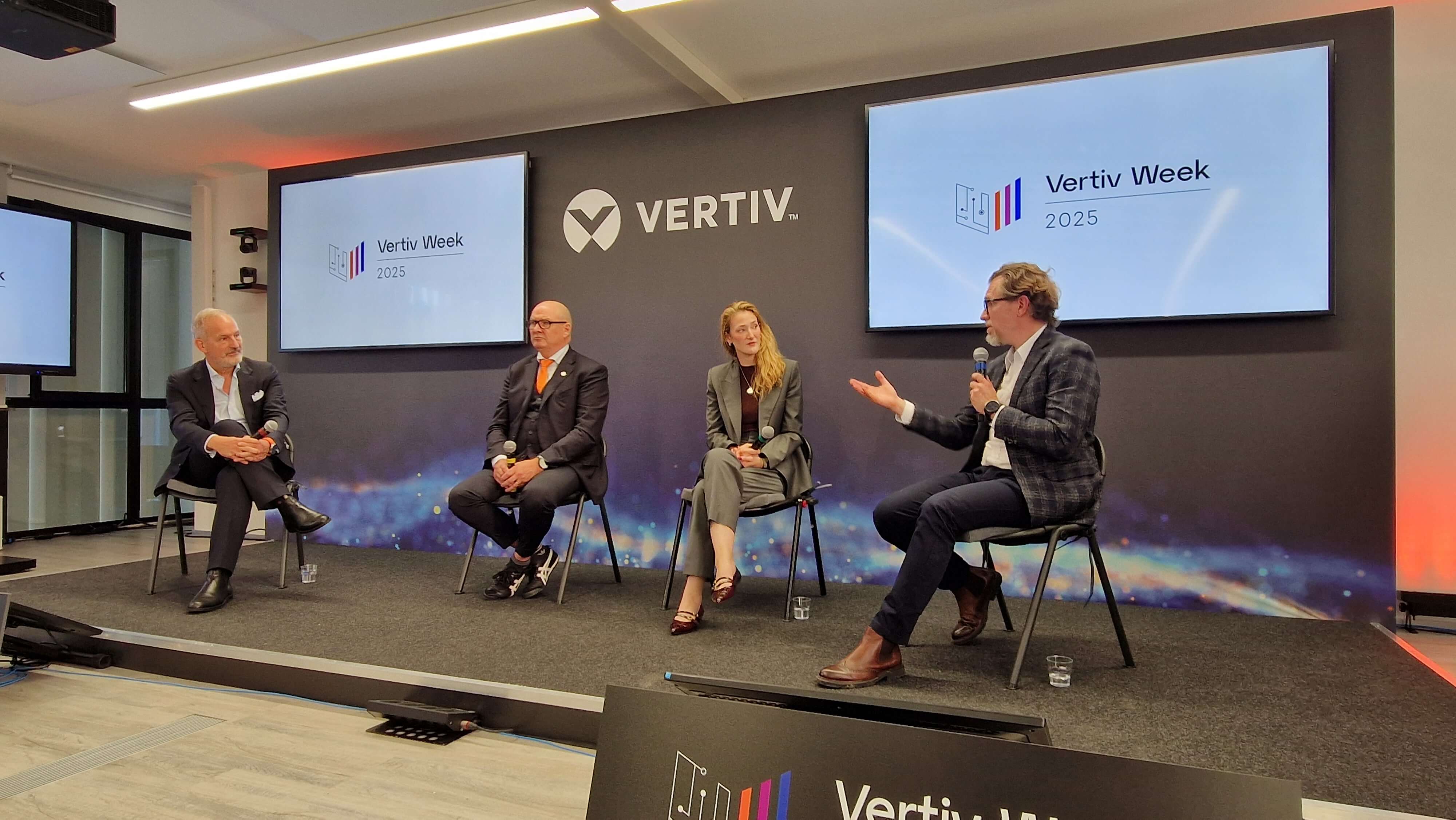
Continua a leggere questo articolo
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business

VITA DA CIO
-

In A2A, IT e business si muovono a ritmo di jazz
12 Feb 2026 -

Cosa hanno raccontato i CIO nel 2025
26 Dic 2025 -

«Rimettere la “T” al centro dell’IT»: la visione di Enrico Andrini, CIO di Bonfiglioli
16 Dic 2025 -

Dal supercalcolo al pensiero critico: la figura del CIO secondo Dario Pagani (Eni)
27 Nov 2025 -

Modernità e rapidità d’esecuzione: l’IT di Hyundai come ponte tra culture e innovazione
06 Nov 2025


















