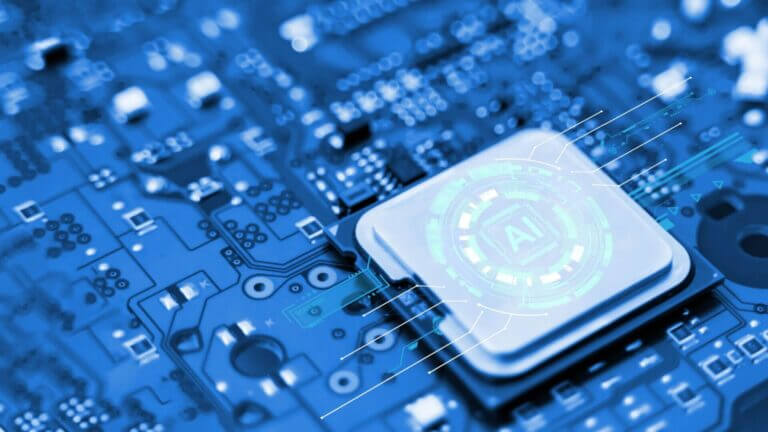Il 2026 segnerà un punto di svolta per chi guida l’IT: l’adozione accelerata dell’AI generativa, il debutto operativo degli agenti autonomi, la pressione crescente su costi e sostenibilità delle piattaforme, l’urgenza di modernizzare applicazioni e dati per ottenere valore misurabile dalle iniziative digitali. In questo scenario, la CIO Agenda 2026 si allarga e si complica: non basta più gestire la tecnologia, serve strutturare un modello capace di connettere strategia, operation e innovazione continua.
la guida
CIO Agenda 2026: 5 domande da porsi e ruolo dell’AI
Le priorità strategiche secondo Gartner. Le sfide dei CIO per modernizzare sistemi, dati e modelli operativi in vista dell’evoluzione di AI generativa e agenti autonomi. E bisogna passare dalla “gestione di task” alla “value execution”
Giornalista

Continua a leggere questo articolo
Aziende
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business