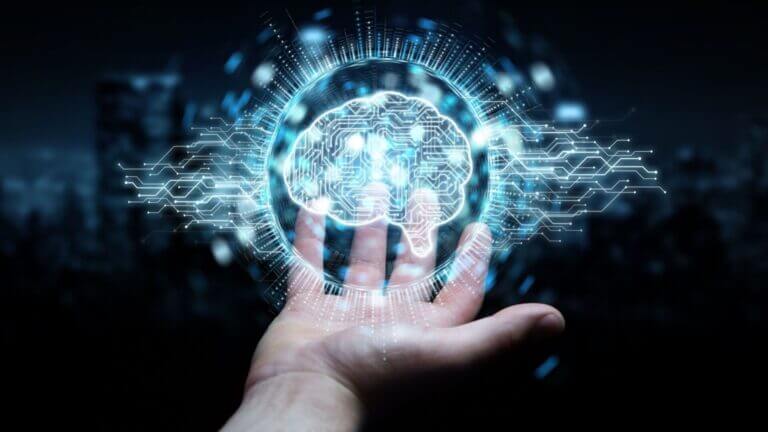La competizione tecnologica, il ruolo dell’AI, le competenze. E poi il mestiere del CIO: guidare senza spegnere il cervello delle persone, difendere l’essenziale, anticipare il futuro. Dario Pagani, Head of Digital & IT e CIO di Eni, parla con la schiettezza di chi vive la tecnologia come un mestiere, una responsabilità e – soprattutto – un atto di curiosità continua. Quello del CIO, racconta, non è mai stato un ruolo così sfidante: perché tutto cambia in fretta, mentre la capacità di “farsi le domande giuste” diventa il vero terreno di leadership.
Indice degli argomenti
La tecnologia è sempre stata un asset distintivo per Eni. Che cosa significa oggi essere una “tech company” nel settore dell’energia?
Essere una tech company non significa solo avere la tecnologia – hardware, software o infrastrutture – ma saperla sviluppare, controllare, e usare. La potenza è nulla senza controllo, diceva uno spot di anni fa, ed è ancora più vero oggi. Puoi comprare macchine potentissime, ma se non hai le competenze interne non vai da nessuna parte. Ecco perché per noi non è solo centrale la tecnologia “fisica”, ma il software, gli algoritmi, il capitale umano. Il mondo dell’energia sta cambiando velocemente: se vuoi esserne protagonista, devi costruire competenze, alimentare ricerca, essere curioso.
Parli spesso dell’importanza del software e delle competenze. Perché è un vantaggio competitivo così forte?
Perché oggi tutti possono acquistare un’infrastruttura potente. Ma non tutti sanno come utilizzarla. È come avere una macchina da corsa senza pilota. Noi siamo partiti 15–20 anni fa investendo su modelli matematici, parallelizzazione, supercalcolo, GPU quando quasi nessuno le usava. Lì si è costruito un vantaggio reale: sulla capacità di risolvere problemi complessi più velocemente degli altri. E questo vale in tutto: geoscienze, meteorologia, materiali, simulazioni. Il vantaggio è nel know-how che sviluppi nell’usarlo. È per questo che le competenze tecnologiche sono interne all’azienda: sono il nostro vero asset.
State investendo molto anche nel quantum computing. A che punto siete?
Abbiamo team dedicati, laboratori in funzione, prime sperimentazioni e use case già modellati su emulatori e simulatori. Il nostro obiettivo è avere, in pochi anni, una macchina full stack con software integrato. Il quantum non servirà per tutto, ma in alcuni casi farà la differenza: risolvere problemi in tempi rapidi con consumi accettabili. E per un’azienda energetica questo è un passo importantissimo.
Oltre al quantum, quali tecnologie avranno l’impatto maggiore nei prossimi anni?
Vedo due frontiere importanti. La prima è l’informatica neuromorfica: un modello molto più vicino al cervello umano, con latenza minima e capacità di risposta altissima. Può rivoluzionare robotica, edge, controllo industriale. La seconda riguarda modelli molecolari o reti neurali realizzate con logiche fisiche diverse dalle attuali. Sono mondi che possono sbloccare un’efficienza enorme rispetto ai sistemi convenzionali. E poi, naturalmente, l’intelligenza artificiale, ma quella “vera”, non l’automazione mascherata.
Proprio sull’intelligenza artificiale: qual è la tua priorità oggi in azienda?
Capire davvero dove crea valore. C’è una bolla evidente: molta “AI” oggi fa cose marginali, come leggere mail o fare summarization. Può essere utile, certo, ma non cambia il modo di fare business. Il punto è un altro: visto che la tecnologia non è più un vincolo, che cosa vogliamo davvero cambiare nel modo di lavorare? È qui per me che nasce il problema: la povertà di pensiero: per cambiare un processo, serve profondità, studio, consapevolezza e coraggio.
Spesso si parla di aumentare la produttività senza incrementare le risorse. In che modo l’AI può trasformare questo obiettivo in realtà?
L’AI può diventare un moltiplicatore incredibile. Non è RPA, non è automazione. È ridisegno dei processi. La questione non è “fare di più con meno”, ma “fare quello che serve”, Però serve cultura: non possiamo spegnere il cervello delle persone. Se deleghi tutto alla macchina, non sai più distinguere cosa è vero da cosa non lo è. E questo, nel lungo periodo, impoverisce il pensiero critico.
Molti temono che l’AI riduca le competenze di chi la usa. Come si difende il know-how?
È la mia più grande preoccupazione. Se deleghi tutto, disimpari. È successo col GPS: se ti si spegne il telefono, non sai tornare a casa. Il rischio è enorme: stiamo progressivamente riducendo le capacità cognitive. La differenza la farà chi mantiene curiosità, spirito critico e capacità di interpretare il contesto. Per questo noi proteggiamo le competenze distintive, soprattutto quelle che i grandi player tecnologici cercano di acquisire attraverso la richiesta di nostri dati o esperienze.
Dal punto di vista organizzativo, come è strutturata oggi la funzione ICT di ENI?
La funzione ICT di Eni è strutturata in modo da coniugare governance centrale e capacità di esecuzione distribuita. In Italia conta circa 650 persone, mentre a livello globale arriva a circa 1.200. Il modello è a matrice: da un lato una governance forte, dall’altro un’esecuzione federata nelle diverse aree di business. Ogni area – dalla chimica alla raffinazione, dal trading alla mobilità – è supportata da un Digital Business Partner dedicato, che funge da punto di contatto tra tecnologia e business. A livello centrale opera una funzione di Strategy & Governance, che presidia architetture, standard, procurement e controllo dei costi. Accanto a questa, ci sono altre funzioni verticali: cybersecurity, infrastrutture e tecnologie e servizi all’utente finale. Completano il quadro due centri di competenza focalizzati su ambiti strategici: intelligenza artificiale e supercalcolo. Per quanto riguarda la cybersecurity non esiste autonomia locale, ma è rigorosamente centralizzata, con una divisione netta tra chi progetta e chi opera.
E a livello di budget come gestisci run e innovazione?
Abbiamo eliminato il vecchio modello di budget annuale definito a settembre-ottobre e adottato un capital budgeting rolling, concordato insieme al business. Le iniziative innovative entrano se generano valore misurabile. In modo molto spannometrico, potrei dire: 75-80% run, 20-25% innovazione. Ma è una distinzione che non mi convince: quando aggiorni un’infrastruttura, spesso fai innovazione. Quando cambi un processo, innovi. L’importante è capire dove generi valore e dove mitigare rischio.
Cosa rende difficile oggi il mestiere del CIO?
Il mestiere del CIO è difficile soprattutto per due motivi. Il primo è la velocità con cui tutto cambia: l’intelligenza artificiale evolve a cicli settimanali, non più a cicli annuali. Quello che impari oggi rischia di essere superato tra un mese e questo crea una pressione costante. Il secondo è l’omologazione. Vedo un po’ ovunque la tendenza a fare quello che fanno gli altri: “l’ha detto un vendor”, “l’ho visto in un video”, “lo fanno anche i nostri competitor”. È come se ci fosse la tentazione di seguire la corrente invece di capire davvero cosa serve. Ecco perché il ruolo del CIO è diventare una sorta di freno intelligente: non per bloccare l’innovazione, ma per riportarla all’essenziale. Fare le domande giuste, evitare le mode, scegliere ciò che ha senso per l’azienda. Oggi serve più discernimento che mai.
Cosa consiglieresti a un giovane CIO?
Tre concetti semplici, ma fondamentali. Il primo è studiare, sempre. Non smettere mai di imparare, perché in questo mestiere quello che sai oggi può non bastare più domani. La curiosità è una forma di sopravvivenza professionale.
Il secondo è coltivare apertura e generosità: ascoltare gli altri, condividere, mettersi in gioco. Nessuno fa innovazione da solo e la capacità di costruire relazioni è spesso più importante della tecnologia stessa.
Il terzo è essere originali. Non inseguire modelli che non ci appartengono solo perché sembrano funzionare altrove. Meglio sbagliare con le proprie idee che rincorrere quelle degli altri.
E soprattutto, non pensare mai di essere arrivato. Nel nostro mondo, se ti fermi, in 6 mesi sei già superato.
E fra dieci anni, che CIO immagini?
Spero che il CIO del futuro sia un manager capace di unire tecnologia, etica, cultura, umanità. Che sappia farsi domande, prima ancora di cercare risposte. E che metta l’uomo al centro, perché la tecnologia senza l’uomo non ha anima.